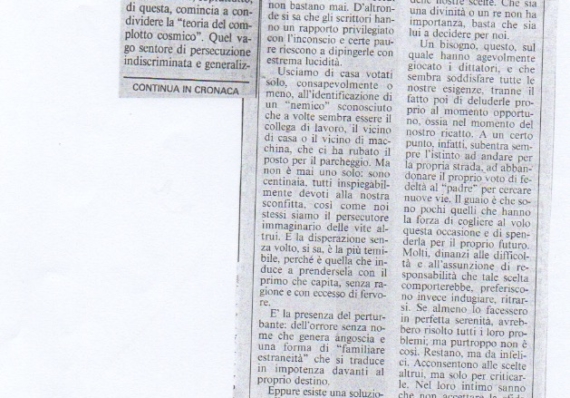Caos da traffico. Bus lumaca. Metrò fermo in galleria. Angoscia, turbamenti, sconforto e disperazione. Tutto sembra cospirare contro di noi. Non è l’ultimo remake di “Alien”, anche se ormai il vivere quotidiano è sempre più simile agli scenari catastrofici della fantascienza e, soprattutto, di questa, comincia a condividere la “teoria del complotto cosmico”. Quel vago sentore di persecuzione indiscriminata e generalizzata che è l’unica spiegazione plausibile che riusciamo a darci davanti al fatto che gli aerei non decollano, i treni sono in ritardo, il traffico è bloccato, il telefono squilla in continuazione, le scadenze si fanno sempre più ravvicinate e i soldi non bastano mai. D’altronde si sa che gli scrittori hanno un rapporto privilegiato con l’inconscio e certe paure riescono a dipingerle con estrema lucidità.
Usciamo di casa votati solo, consapevolmente o meno, all’identificazione di un “nemico” sconosciuto che a volte sembra essere il collega di lavoro, il vicino di casa o il vicino di macchina, che ci ha rubato il posto per il parcheggio. Ma non è mai uno solo: sono centinaia, tutti inspiegabilmente devoti alla nostra sconfitta, così come noi stessi siamo il persecutore immaginario delle vite altrui. E la disperazione senza volto, si sa, è la più temibile, perché è quella che induce a prendersela con il primo che capita, senza ragione e con eccesso di fervore. É la presenza del perturbante: dell’orrore senza nome che genera angoscia e una forma di “familiare estraneità” che si traduce in impotenza davanti al proprio destino.
Eppure esiste una soluzione. Il primo passo utile, generalmente, sta nel riconoscimento del fatto che la nostra vita non è nelle mani degli altri, ma nelle nostre. A dirsi è molto facile, ma come renderlo regola pratica di tutti i giorni?
L’essere umano è naturalmente portato alla dipendenza. Fin dalla nascita deve fare i conti con il fatto che non è autosufficiente, che ha bisogno dell’altro per sopravvivere. Un “altro” che da una parte ci nutre e soddisfa i nostri desideri, e contemporaneamente si nega per soddisfare i propri. “Odiosamato” è lui il responsabile della nostra gioia e delle nostre pene. Così è nei primi anni di vita e così continua ad essere negli anni a venire. La paternità è un’ombra difficile da debellare anche nella maturità, dove si sostanzia sotto la forma di devozione verso un capo autorevole e autoritario, che abbia il potere decisionale delle nostre vite, ma soprattutto che si assuma la responsabilità delle nostre scelte. Che sia una divinità o un re non ha importanza, basta che sia lui a decidere per noi.
Un bisogno, questo, sul quale hanno agevolmente giocato i dittatori, e che sembra soddisfare tutte le nostre esigenze, tranne il fatto poi di deluderle proprio al momento opportuno, ossia nel momento del nostro ricatto. A un certo punto, infatti, subentra sempre l’istinto ad andare per la propria strada, ad abbandonare il proprio voto di fedeltà al “padre” per cercare nuove vie. Il guaio è che sono pochi quelli che hanno la forza di cogliere al volo questa occasione e di spenderla per il proprio futuro. Molti, dinanzi alla difficoltà e all’assunzione di responsabilità che tale scelta comporterebbe, preferiscono invece indugiare, ritrarsi. Se almeno lo facessero in perfetta serenità, avrebbero risolto tutti i loro problemi; ma purtroppo non è così. Restano, ma da infelici. Acconsentono alle scelte altrui, ma solo per criticarle. Nel loro intimo sanno che non accettare la sfida dell’indipendenza è stato un grave torto – il più grave che potessero commettere ai propri danni. E come sempre accade in questi casi, anche la colpa è responsabilità altrui. In altre parole, sono finiti in un circolo vizioso. Ecco perché ritengo che una risposta personale e autonoma sia l’unica che consente di strapparsi alle vane illusioni del “se”. Dopotutto, l’unico nemico che la quotidianità ci impone di fronteggiare siamo noi stessi e le nostre paure. Tanto più grandi e numerose nella città del caos (sopra) e del buio (nel sottoterra del metrò).
Tratto da “Il Messaggero” 20/04/2000