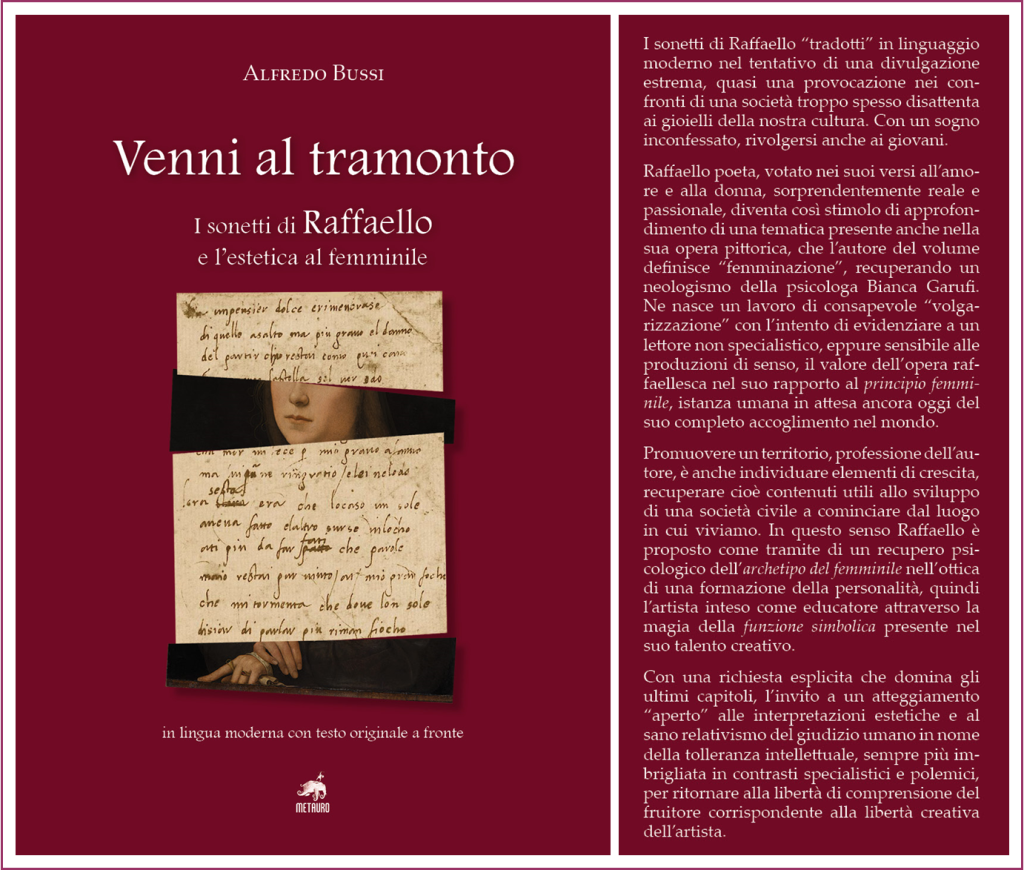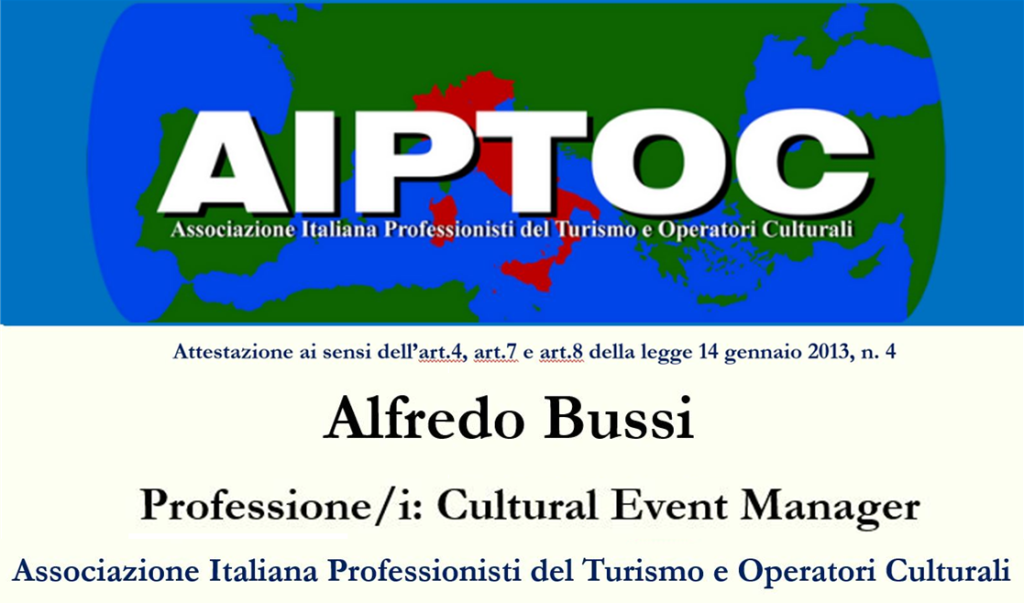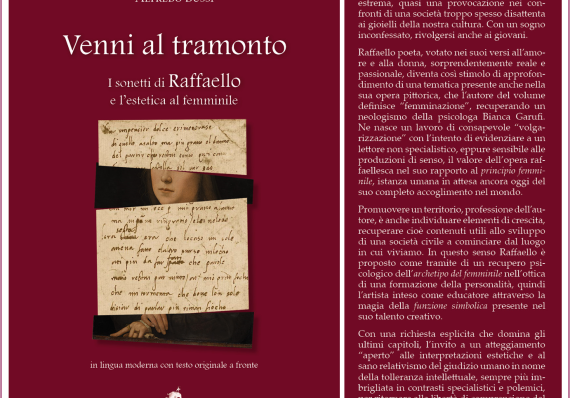
di Alfredo Bussi
L’interesse per la teoria dell’inconscio dimostrata da Cormac McCarthy in un ormai famoso articolo pubblicato nel 2017 sulla rivista Nautilus, è stato un ‘segnale’ significativo e uno stimolo a recuperare interesse per tematiche psicologiche riferite ai fenomeni culturali. In questa ottica, il presente articolo intende portare all’attenzione una teoria specifica sul dinamismo inconscio, quella della «funzione compensatrice» sostenuta soprattutto da Jung. Questa teoria ‘armonizzante’ restituisce alle forme simboliche, in particolare a quelle artistiche, il compito educativo ipotizzato da tanti autori in ambito filosofico ma dal punto di vista di una visione pragmatica. Recuperando così anche l’idea strumentale del fenomeno artistico nel suo compito formativo, troppo spesso dimenticato dal concetto di arte come puro godimento estetico dei sensi, fine a se stessa.
Ipotesi
Un grande merito di Jung è stato quello di attenersi nel corso della sua evoluzione intellettuale ai principi epistemologici della metodologia medica, principi razionali che nel suo caso provenivano innanzitutto dalla filosofia kantiana (di cui era un ammiratore) e che nelle sue indagini gli consentivano di non abbandonare mai il ‘controllo critico’ necessario ad uno scienziato. Allo stesso tempo non ebbe mai timore di procedere oltre nella indagine, cioè di scavalcare l’ambito della oggettività sperimentale e mostrare quello della ipotesi soggettiva, della opinione, della intuizione. Mi fa piacere ricordare, a questo proposito, che fu tra i primi psichiatri a evidenziare la differenza tra i concetti di ‘spiegazione’ e ‘comprensione’ applicati all’indagine medica (Jung, 1914, p.187). Qualcosa di simile a ciò che accade a molti fisici quantistici, scienziati che operano all’interno dei limiti epistemologici pur non disdegnando inferenze speculative che conducono ben oltre quei limiti facendoci ormai apparire la loro scienza come una moderna metafisica, erede della metafisica classica filosofica. Jung è l’esatto corrispondente in psicologia di questo atteggiamento scientifico-speculativo.
Questa premessa mi consente , pur senza sollevarmi da colpe, di iniziare la mia riflessione con una ipotesi euristica palesemente metafisica, idea che solitamente dovrebbe giungere al termine di una esposizione ma che invece preferisco annunciare in apertura come weltanshauung personale che condiziona il mio pensiero: l’idea che l’universo contenga una tendenza insita nella vita organica stessa, una spinta (ὁρμή) finalistica alla consapevolezza. Poniamo dunque che il reale necessiti di una coscienza riflettente con capacità significante per esprimersi e che abbia trovato l’occasione di manifestare la propria voce attraverso una evoluzione della natura, il ‘linguaggio umano’. A quel punto il finalismo della tendenza originaria è in stretta relazione con l’evoluzione della coscienza umana e delle forme simboliche. Evidentemente, verrebbe da ipotizzare, la stessa tendenza archetipica è in un percorso evolutivo se ha necessità di consapevolezza e di un tramite.
In un simile contesto sarebbe fondamentale conoscere il dinamismo di questa tendenza inconscia nel suo manifestarsi a livello psicologico il cui primo dato funzionale risulterebbe essere l’immagine psichica e successivamente il linguaggio (anzi, i linguaggi). Per immagine qui non si deve intendere una riproduzione psichica riferita all’oggetto esterno (percezione), piuttosto una produzione dell’immaginazione che solo parzialmente si riferisce all’ambiente, l’immagine fantastica che simbolizza la realtà oltre la semplice testimonianza dei sensi, funzione culturale che si realizza nella scienza (penso in particolare alla fisica quantistica), nel mito, nella religione, nell’arte.
Il grande valore dato ai profeti, agli artisti, ai geni culturali risponderebbe all’evidenza di coloro che hanno ‘intuito’ l’anima del mondo a livello appercettivo, filtrando con il proprio talento motivi e figure dominanti dell’attività immaginale umana, all’interno di una adeguatezza di senso, significativa a livello collettivo.
Il tutto sarebbe poi condizionato dalla realtà contingente umana, cioè filtrato dall’ambiente e dalla sua storicità. Anche lo stile della ‘voce umana’ espressa nelle varie forme subirebbe una evoluzione adeguata al tempo storico. Di immutabile rimane il potenziale formale, la possibilità di rappresentazioni, non le rappresentazioni stesse.
Ad esempio, oggi questo stile dell’immaginazione creatrice (dopo i forni crematori, la bomba atomica sempre minacciosa e la massificazione dell’anima umana in singole cellule di individualismo cinico) lo vediamo nell’ambito artistico necessariamente votato alla semplicità, decostruito, antiretorico, freddo ma bruciante, antisentimentale eppure struggente, crudele eppure intimamente devoto all’umanità.
Un rappresentante emblematico di questo stile (atteggiamento, se considerato psicologicamente) è lo scrittore Cormac McCarthy.
Un maestro dell’imprecazione esistenziale che però si fa preghiera indicibile, nascosta nel dolore degli errori umani con quel senso universale di speranza (seppur flebile) e rinascita al termine della notte che appartiene da sempre alla psiche (espressa soprattutto nel romanzo La strada). Questa voce sarebbe universale nel momento della simbolizzazione artistica per il semplice fatto che emergono dominanti dell’immaginale con valore collettivo.
Esse in anima
Ma, aldilà delle inferenze metafisiche, come fondare gnoseologicamente l’immaginale ripercorrendo la sua evoluzione (tendenza inconscia > immagine psichica> linguaggio artistico)?
Una possibilità è quella junghiana che teorizza pattern non solo istintivi ma anche psichici, forme a priori dell’immaginazione creatrice paragonabili alle categorie a priori dell’intelletto di kantiana memoria, le quali emergono autonomamente in modalità significanti presenti in tutte le civiltà. La loro essenza è un mistero, chi può dire dove trovi fondamento epistemologico un pattern spirituale? Non c’è alcuna prova che ci consenta di letteralizzare il contenuto (sarebbe una concessione al realismo gnoseologico medievale) ma nemmeno considerarlo flatus vocis di vuote astrazioni (nominalismo). Rimane il fenomeno, la sua realtà psichica, la sua esistenza che si realizza nel “simbolo” a metà strada tra natura e intelletto, una terra di mezzo intuita anche da Abelardo con il suo ‘concettualismo’ in anticipo sulla psicologia moderna.
Un dato di fatto della modernità è proprio questo, nella disputa (sempre attuale) tra ‘esse in re’ ed ‘esse in intellectu’ molti vedono l’‘esse in anima’. Psicologia analitica di Jung e psicologia archetipica di Hillman, su questo concordano appieno.
Immagini, associazioni, appercezioni, sentimenti che non si completano nelle categorie dell’intelletto (sia ben chiaro, funzione preziosissima se però considerata parte di una funzione simbolica significante più vasta). Perlopiù immagini e idee unificanti il razionale e l’irrazionale che segnano tappe dell’evoluzione spirituale umana in direttive dominanti, binari di senso originari condizionanti pensieri e comportamenti. Queste unità funzionali psichiche (Jung, 1907, p.46) vennero definite per la prima volta negli studi sull’associazione verbale ‘complessi a tonalità affettiva’ (Jung–Riklin, 1904, p.88) perché a livello psichico i contenuti inconsci sono sempre accompagnati da una tonalità affettiva. Dal punto di vista dinamico risultano indipendenti dalla coscienza e pertanto ‘autonomi’. Dal punto di vista funzionale, base di partenza è l’immagine, intesa come elemento primario della fantasia creatrice, alla quale segue l’‘idea’ come suo sviluppo astrattivo operato dall’intelletto. Percezione sensoriale, rappresentazione, tono affettivo vivono in queste unità autonome. Verranno poi giustamente differenziate da Jung in base alla loro rappresentatività personale o impersonale con la distinzione tra complesso e archetipo ma è bene ricordare che nel vissuto psicologico astrazioni non esistono, la fluidità e il dinamismo sono la vera esperienza.
Un dinamismo psichico affascinante e misterioso, problematico ma creativo tra conscio e inconscio che McCarthy considerava attentamente, come vedremo.
Siamo nel cuore della psiche, quando si fa voce della tendenza biologica (inconscio) fin dentro i fondamenti originari dell’immagine simbolica, delle idee collettive, dell’affettività. Jung la chiamava psichificazione (Jung, 1937, p.134), il salto misterioso tra pattern biologico e immagine psichica.
Si parla dunque di fenomenologia simbolizzatrice unificante presente in potenza nella struttura cerebrale, lenta nel suo delinearsi storico, preziosa nei portatori di civiltà. Come dimenticare che le rare catarsi e metanoie epocali da sempre si manifestano inizialmente nella parola di pochi e permettono al mondo il suo rinnovarsi o semplicemente il suo evolversi?
Così appaiono i profeti culturali.
Sciamani
Sotto questo registro mi è apparso Cormac McCarthy, ultima voce in ordine di tempo di una storia millenaria di profeti culturali, voce ‘sciamanica’ per la qualità di relazione tra contenuti fondanti (inconscio) e contenuti dello spirito del tempo (conscio), nella fattispecie sciamano della terra dei Pueblo (se vogliamo riconoscere in lui anche un legame intimo anima-terra). Insistendo su questa interpretazione, sosteniamo come realtà lo sciamanesimo culturale, definendolo come capacità talentuosa di far emergere un contenuto situato tra natura e spirito necessitante di essere portato a consapevolezza, importante per l’equilibrio psichico personale e collettivo. Come è stato detto, ‘lo sciamano agisce a favore degli uomini. Il ruolo dello sciamano è per sua natura benefico’ (Marazzi, 2009).
Sulla scrittura sciamanica altri (Manifesto dello scrittore sciamano – www.dissipatio.it) hanno scritto molto meglio di quanto possa fare io, qui vorrei solo suscitare interesse sulla caratteristica dinamica di questo scrivere che vive di relazione tra conscio e inconscio. Ogni sciamano ha una tecnica, quella di McCarthy si mostra (oltre che nella suddetta relazione) nel gioco oscillante tra arcaismo e contemporaneità.
Lo dico diversamente in una sintesi estrema, l’immagine vive di arcaismo, condensazione, concretismo e si disvela numinosamente, cioè con una tonalità affettiva che gli consente di imporsi: l’esempio principe è il bambino del romanzo La strada, a fronte della realtà distopica chiede insistentemente al padre (ai limiti della ossessività): “portiamo il fuoco?” (McCarthy, 2007, passim), ed è catarsi attraverso una semplice immagine archetipica portatrice di analogie simboliche che attraversano la storia culturale umana.
L’idea invece vive di astrazione e differenziazione e il suo culmine è nell’analisi concettuale al termine di un percorso intellettuale (anch’esso comunque non senza tonalità affettiva). In questo caso, l’exemplum è rappresentato dal personaggio di Alicia in Stella Maris allorquando esprime giudizi speculativi di grande impatto come “il mondo non ha creato un solo essere vivente che non intenda distruggere” (McCarthy, 2023, p.24).
Come vediamo, nei due casi siamo agli estremi formali, nel bambino il concretismo dell’immagine psichica originaria senza tempo, in Alicia la razionalizzazione dell’idea come punto di arrivo intellettuale. E sono anche gli estremi stilistici dei due romanzi.
Però, sia nel primitivismo psicologico del bambino con l’immagine del fuoco interiore, sia nell’intelletto di Alicia con l’idea-forza di una natura contradditoria, la sensazione del lettore è sempre la stessa, la presenza nell’agire psichico dei personaggi di un ‘tendere verso’ che non è compiutamente dominato alla coscienza dell’Io, piuttosto un sottofondo fenomenologico che parte dalla predisposizione intima di quel dato individuo, forse fin dentro la biologia e che non sappiamo definire altrimenti se non come inconscio. I personaggi letterari in questione sono il racconto di questa interiorità psicologica. Questa ipotetica base interiore ontologica fu, come sappiamo, rivoluzione culturale e terra di confronto. Libido, istinto di potenza, interesse psichico, tendenza, energia psichica…tante le definizioni per una inferenza epocale. Degno di nota ricordare che in alcune occasioni Jung paragonò il suo concetto di ‘energia psichica’ allo “slancio vitale” di Bergson (considerato però troppo biologico e troppo poco psicologico) e, in una conferenza (On Psychological Understanding) tenuta a Londra nel 1914, al concetto classico di ‘hormé’.
Inconscio e dintorni
Anche per McCarthy il riflettere sulla immaginazione conduceva alla fondazione psico-biologica del pensiero umano. Evidentemente c’era abbastanza carne al fuoco nel suo pensiero al punto tale da decidersi nel 2017 ad esternare eccezionalmente (prima e unica volta) la propria visione sulla teoria dell’inconscio in relazione al linguaggio. Ed è così che lo abbiamo scoperto ‘senior fellow’ del Santa Fe Institute e autore dell’ormai famoso articolo Il problema di Kekulè pubblicato sulla rivista Nautilus (McCarthy, 2017). Molte le domande nella sua analisi ma tutto il testo ha il tono dell’interrogarsi: “L’inconscio sembra sapere molte cose, ma cosa sa di sé? Sa che dovrà morire? Che cosa pensa della morte? Può risolvere diversi problemi in una volta? Sa solo quello che diciamo? O ha un accesso più diretto al mondo esterno?
E da qui si dipanano tutta una serie di considerazioni ipotetiche, in uno stile tutto suo che punta più al suscitare che al dettagliare. Dobbiamo innanzitutto essergli grati se, dall’alto del suo credito artistico, ha recuperato un contenuto teorico diventato decisamente popolare e in quanto tale inevitabilmente depotenziato (se non banalizzato), l’inconscio per l’appunto. Ma il fascino del suo articolo è nel racconto di un abisso intellettuale, il mistero inquietante del “fantasma”, cioè dell’immaginale legato alla base istintuale in quanto processo spontaneo. Il mistero dell’immaginazione creatrice che trasforma il dinamismo biologico in cultura e foriero di tante interpretazioni filosofiche, dall’ ‘autoliberazione’ dall’istinto biologico stesso (Cassirer, 1982) alla mutua relazione adattiva tra funzioni o, negativamente, come prigione in astratte forme simboliche.
A questo proposito, le considerazioni junghiane sull’immaginazione sono illuminanti:
‘Dobbiamo presumere che la struttura cerebrale così com’è data non debba le sue qualità esclusivamente all’azione delle circostanze ambientali ma in ugual misura a una proprietà specifica e autonoma della materia vivente, cioè a una legge che è data con la vita stessa.
Pertanto anche l’immagine primordiale [funzione simbolica] da un lato va riferita indubbiamente a determinati processi ambientali, dall’altro però altrettanto indubbiamente a determinate disposizioni interiori della vita spirituale e della vita in genere. Alla luce l’organismo contrappone l’occhio e al processo naturale lo spirito contrappone un’immagine simbolica la quale coglie il processo naturale proprio come l’occhio la luce’ (Jung, 1921,p. 454).
Per non parlare di Schopenhauer che perentoriamente scrisse: ‘L’idea [creativa] si differenzia dal concetto nel quale non si può tirar fuori più di quanto vi è stato collocato, l’idea è un organismo vivente che è dotato di potenza generatrice, capace di produrre ciò che in esso non era stato introdotto’. (Schopenhauer, 1999)
Come ha evidenziato Roberts Avens, il fondamento immaginale è un abisso ben riconosciuto anche da Kant allorché si trovò a delineare il concetto di ‘immaginazione trascendentale’(Avens, 1985) intesa come sintesi suprema di una funzione misteriosa presente nella ragione, oggi diremmo sin dentro la vita organica (e forse la materia). Ma come notò Heidegger, Kant si ritirò di fronte alla supremazia immaginativa e ritornò al predominio delle categorie dell’intelletto e alla loro ideale ‘chiarezza’ razionale (Heidegger,1989).
Dinamica e relazione
Dicevo più su della relazione conscio-inconscio, è possibile definirlo meglio questo dinamismo che viene evidenziandosi sotto lo stimolo dell’articolo di McCarthy?
Un orientamento consapevole (weltanschauung) in tal senso già esiste, nacque sull’onda delle prime teorie freudiane come argomento di indagine per un gruppo di psicologici tra loro coevi, pionieri della tematica di cui ci occupiamo ed è ancora attuale non avendo perso nulla della sua persuasività: la funzione compensatoria dell’inconscio.
Teoria capace di restituire un finalismo al dinamismo psichico e conseguentemente all’energia vitale del simbolo culturale.
Alfred Adler fu il primo, nel 1907, a delineare il meccanismo compensatorio limitandolo però al solo bilanciamento del complesso di inferiorità (Adler,1907, p.73), dunque risposta psicologica intesa come ‘costruzione ausiliaria’ Anche Otto Gross e Anton Delbruck avevano accennato a questa funzione ma fu soprattutto Jung ad ampliare successivamente il concetto di compensazione al bilanciamento funzionale dell’apparato psichico, in relazione al dinamismo tra conscio e inconscio (Jung, 1914, p 209).
Se la funzione simbolica è una voce della relazione Io-inconscio, allora la teoria della
‘compensazione regolatrice’ dell’inconscio definisce questa relazione nel senso di una funzione finalizzata all’adattamento vitale (Jung, 1921, p.430).
Più nel dettaglio, se la coscienza è quella unità funzionale riferita all’Io che vive soprattutto di pensiero indirizzato formulato in linguaggio, allora è giocoforza che tenda a separare, differenziare, escludere cioè a irrigidire i contenuti a scapito di una potenziale completezza.
E soprattutto a scapito della personale ‘individuazione’. L’inconscio biologico (il suo ‘élan’) contrasterà questa tendenza anti-dinamica della coscienza e si insinuerà con le immagini compensatorie per procedere ulteriormente nel dinamismo psichico. In altri termini l’inconscio agisce sull’unilateralità di un atteggiamento assunto dalla coscienza divenuto dominante e prevaricante (generalmente racchiuso nel concetto di ‘spirito del tempo’) e risolvibile energeticamente solo con l’integrazione dell’istanza inconscia. Un vecchio paragone, evidenziato da Jung, voleva la coscienza simile all’occhio, del quale si dice abbia un campo visivo e un piano prospettico. La coscienza come l’occhio può cogliere nel proprio campo solo pochi contenuti contemporaneamente e solo un numero limitato può raggiungere il più alto grado di consapevolezza. Ricordiamo che sono stati i fenomeni psicopatologici a suscitare questa ipotesi, soprattutto le nevrosi dove, contro la norma, l’inconscio entra in conflitto con la coscienza. In pratica la tendenza selettiva dell’Io esige una direzione e la direzione implica l’esclusione di tutto ciò che in quel momento è estraneo al contenuto. Il risultato è una certa unilateralità nell’orientamento cosciente. I contenuti esclusi dalla direzione prescelta e inibiti cadono nell’inconscio ma, data la loro effettiva esistenza, essi costituiscono un contrappeso che aumenta di intensità energetica e in casi abnormi crea tensione patologizzante. Però, è utile ribadirlo, la psicologia ci dice che normalmente la compensazione ad opera dell’inconscio non costituisce un contrasto ma un naturale bilanciamento dell’orientamento cosciente. Sembra dunque che il suo finalismo sia quello del miglior adattamento possibile, adattamento inteso come completezza di istanze esteriori ed interiori della individualità.
Pertanto, la compensazione psichica corrisponderebbe all’analoga funzione in fisiologia conosciuta come ‘autoregolazione organica’.
McCarthy non arriva a questi esiti ma il dinamismo inconscio-conscio delineato nell’articolo del 2017 evidenzia chiaramente la relazione profonda tra le funzioni, proprio come sostiene l’orientamento teorico della compensazione.
Ora, tutte le forme simboliche, intese nel senso precipuo formulato da Ernst Cassirer (Cassirer, 1968), sono portatrici della compensazione perché il ‘simbolo’ è il trasformatore psichico del dinamismo energetico (Jung, 1928, p.55).
L’arte, in tal senso, è una delle forme predilette della compensazione per la sua capacità di divulgazione universale dei simboli, un potere trasversale di comprensibilità. O almeno così dovrebbe essere.
Anche la letteratura di McCarthy incontrerebbe un profondo finalismo culturale nella teoria della compensazione. Ad esempio, sotto questa ipotesi euristica, la domanda arcaica sul ‘fuoco’ interiore del protagonista del romanzo La strada troverebbe la propria deiscenza, arriverebbe alla sua ‘maturazione’. Nel momento in cui pensiamo l’immagine del fuoco come compensatoria alla coscienza, la sua esoterica primitività assume una tendenza specifica, interpretata come un’apertura contenutistica nella coscienza, un possibile percorso di autoregolazione spirituale. Ovviamente solo la ‘comprensione’ può portare a termine l’assimilazione del contenuto simbolico, la ricerca ermeneutica dovrebbe allora seguire comparativamente il senso storico di quella immagine simbolica, indagandolo, razionalizzandolo e restituirlo alla coscienza sotto forma di nuova consapevolezza, cioè nella dimensione culturale ma con valore psichico (energetico-affettivo).
E questo può avvenire in una qualunque forma, adeguata alla costellazione di senso che esprime in nuce, perché le forme simboliche dell’arte, della scienza, del linguaggio, della mitologia sono paritarie dal punto di vista del vissuto psicologico. E il fuoco, in effetti, è un ‘simbolo’ antichissimo (motivo archetipico) portatore di senso e di analogie in campo artistico, letterario, religioso e, last but not least, in chiave di analitica psicologica (Jung, 1912, p.168)
Si aprirebbe ora l’analisi del contenuto, non prevista nel presente articolo che considera solo l’aspetto formale della problematica, ma ovviamente è proprio nell’aspetto culturale che il simbolo trova la sua legittimazione formativa. Da qui inizierebbe l’umanesimo del processo naturale giunto alla realizzazione del quadro istintuale, la costruzione del senso.
La scoperta del fuoco
Concludendo, vorrei ribadire il valore euristico della relazione compensatoria conscio-inconscio, nella quale si rivela l’intento formativo del simbolo (ovviamente nel caso di McCarthy di tipo artistico), il suo scopo equilibrante in vista di una maggiore completezza psicologica che non si realizza (sempre nel caso dell’arte) solo nel godimento estetico ma tende al valore educativo per mezzo della comprensione del simbolo stesso. Non sono pochi nella storia dell’estetica filosofica coloro che hanno attribuito all’arte un compito educativo, ritenendo la creazione artistica strumentale all’uomo. Come notava il filosofo Abbagnano, la famosa teoria catartica dell’arte ‘non è che l’accentuazione della sua strumentalità educatica’. La qualità psicologica compensatrice chiarisce la dinamica di questo compito, la possibilità per l’arte di essere espressione di contenuti necessari a bilanciare le concezioni sclerotizzate del conscio (mainstream). Perentorio Jung quando dichiara che ‘l’artista non è solo colui che rappresenta la realtà, ma anche un creatore e dunque un educatore; le sue opere hanno infatti valore di simboli che tracciano le linee di uno sviluppo futuro’. E questo è sempre stato il ruolo degli artisti, fenomeni culturali di autoregolazione spirituale della società e anticipatori di cambiamenti. (Bussi A., 2020, p.54).
Come nota anche McCarthy ‘è difficile sfuggire alla conclusione che l’inconscio stia lavorando sotto una compulsione morale per educarci’ (McCarthy, 2017). Ma il tono dello scrittore è più interrogativo che affermativo perché questa formatività della funzione inconscia è una dinamica naturale di relazione con la coscienza nella quale la direzione può concretizzarsi in forme positive o negative per l’individualità e dunque solo successivamente sottostare a un giudizio di valore.
Ad esempio, la numinosità dei contenuti inconsci può determinare pericolose identificazioni se non assimilati dalla coscienza e la psicologia ha da tempo evidenziato i relativi rischi per l’individuo. Nella dimensione psichica, l’immaginazione non sottoposta alla relazione cosciente si manifesta spesso ‘problematicamente’, come ha raccontato artisticamente McCarthy in tante sue opere, proprio perché l’inconscio non è sottoposto all’analisi consapevole della coscienza.
Si dimentica in questi casi la dinamica di relazione, l’unica modalità che evita il dominio incontrollato di una delle due funzioni, dominio patologizzante che a livello personale crea sofferenze psichiche e a livello collettivo derive distopiche (Bussi G., 2019, passim).
Pertanto, riassumendo, la compensazione è fenomeno psichico dinamico, il valore più o meno vitale di questo processo naturale è dato dalla risultanza finale della forma ideo-affettiva autonoma che si realizza compiutamente nel confronto con la coscienza.
Allo stesso tempo, l’opera di Cormac McCarthy ci insegna che questo confronto non può realizzarsi in una qualche “struttura” culturale esterna ma solo da personali mutamenti di atteggiamento psichico.
Infatti la presenza dominante nei suoi personaggi letterari dell’istinto da un lato e delle ‘idee-forza’ dall’altro, rimandano al contradditorio animo umano individuale, ago della bilancia.
La possibilità di cambiamento comincia nei singoli attraverso una trasformazione delle tendenze per mezzo dell’accoglimento dei simboli compensatori.
Se mai si giungerà ad un risultato collettivo, questo accadrà per mezzo della somma di singole trasformazioni individuali.
Per questa ragione la responsabilità interpretativa del simbolismo immaginale dell’inconscio spetta al singolo nella dimensione esistenziale della ‘possibilità e rischio’.
Non per nulla, seguendo McCarthy, parliamo di un essere vivente portatore di un ‘fuoco’, cioè un contenuto psichico ancora numinosamente attivo e valido nella sua evoluzione culturale significante. Fuoco purificatore o fuoco distruttivo lo deciderà il vissuto, anticipatamente possiamo solo utilizzare la funzione psichica irrazionale dell’intuizione che ha tanta importanza nella psicologia junghiana come ‘comprensione istintiva’ (Jung, 1921, p.467).
In ogni caso, accettando il confronto, scopriremo individualmente il significato del motivo archetipico del fuoco interiore, motivo che si rinnova, come abbiamo visto, adeguandosi alla contemporaneità, e decidere se assimilarne il senso, rifiutarlo o altro.
Come è stato sostenuto da tanti studiosi, la relazione dialettica con i motivi originari conduce inevitabilmente alla dimensione etica. La scelta condizionerà il pensiero e l’esistenza del soggetto, formandone il destino umano. Siamo giunti così allo sfociare della relazione simbolica nella vita, dove finalmente potrà fluire compiutamente nel processo energetico esistenziale in nome di una vissuta individuazione psicologica.
Un compito che oggi sembra fuori dal tempo, sovrastato da una ‘liquidità interiore’ che sa di sconfitta umana. E l’esistente, in tutto questo, perde senso e vitalità.
Tornano alla mente le parole compensatorie dei geni culturali per riflettere su possibili strumenti di recupero formativo, come in Keats quando affermava ‘chiamate il mondo la valle del fare anima, allora scoprirete a cosa serve il mondo’.
Ecco l’artista educatore del suo tempo e, in casi eccezionali, anticipatore. Come diceva Jung, «un argomento sul quale ci si potrebbe trattenere a lungo» (Jung, 1922, p.354).
Alfredo Bussi
23/09/2025
Bibliografia
Adler, Alfred, Studie über Minderwertigkeit von Organen, 1907, Berlino
Avens, Roberts, L’immaginazione è realtà, Edizioni di Comunità, 1985, Ivrea
Bussi, Alfredo, Venni al tramonto – i sonetti di Raffaello e l’estetica al femminile, Metauro edizioni, 2020, Pesaro
Bussi, Greta, Distopia tra presente e futuro in Freud e Jung, Uniurb, 2019, Urbino
Cassirer,Ernst, Saggio sull’uomo, Armando editore, 1968, Roma
Cassirer, Ernst, Filosofia delle forme simboliche, La nuova Italia, 1982, Firenze
Heidegger, Martin, Kant e il problema della metafisica, Laterza, 1989, Roma-Bari
Jung, Carl Gustav, L’associazione verbale negli individui normali, 1904 – Opere complete vol. 2
Jung, Carl Gustav, Psicologia della dementia precox, 1907 – Opere complete Vol.3
Jung, Carl Gustav, Simboli della trasformazione, 1912/1952- Opere complete, Vol. 5 Jung, Carl Gustav, Sulla comprensione psicologica di processi patologici, 1914- Opere complete, Vol.3
Jung,Carl Gustav, Importanza dell’inconscio in psicopatologia, 1914 – Opere complete, Vol.3
Jung, Carl Gustav, Tipi psicologici,1921 – Opere complete, Vol.6
Jung, Carl Gustav, Psicologia analitica e arte poetica, 1922 – Opere complete, Vol. 10
Jung, Carl Gustav, Energetica psichica, 1928 – Opere complete, Vol. 8
Jung, Carl Gustav, Determinanti psicologiche del comportamento umano, 1937 – Opere complete, Vol.8
Marazzi, Ugo, Testi dello sciamanesimo siberiano e centro-asiatico,UTET, 2017, Milano
McCarthy, Cormac, La strada, Einaudi, 2007,Torino
McCarthy, Cormac, Stella Maris, Einaudi, 2023,Torino
Schopenhauer, Arthur, Il mondo come volontà e rappresentazione, Mondadori, 1999, Milano
Citazioni web
McCarthy, 2017, https://nautil.us/the-kekul-problem-236574/ accesso: 27-12-2023 ore:12:45
Manifesto dello scrittore sciamano, https://www.dissipatio.it/scrittore-sciamano/ accesso: 27-12-2023 ore 12:50
Alfredo Bussi – Operatore Culturale
Nato a Pesaro, classe 1961, svolge la professione nelle Marche occupandosi principalmente di “storytelling culturale” attraverso l’ideazione e organizzazione di eventi pubblici. Nella sua attività pluridecennale è stato ideatore, tra l’altro, del festival itinerante dantesco ‘Umanesimo del Gusto’ contribuendo alla riscoperta dei luoghi danteschi marchigiani. Si è poi dedicato a eventi per celebrazioni ufficiali (Rossini, Leopardi, Raffaello, etc.) in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche.
In campo editoriale, nel 2016 ha pubblicato Come queste Marche – idealismo della marchigianità e nel 2020, in occasione delle celebrazioni raffaellesche, Venni al tramonto – i sonetti di Raffaello e l’estetica al femminile per la Metauro Edizioni.
Associato AIPTOC con la qualifica professionale Cultural Event Manager (classificazione EQF).
Contatto: alfredobussi@yahoo.it